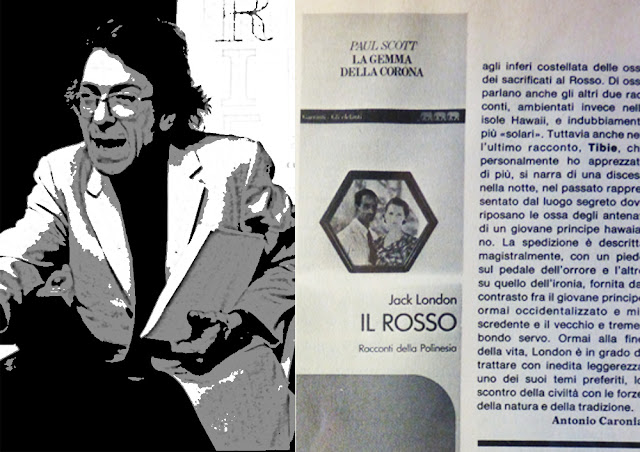In un recente convegno (Teoria dei sistemi e razionalità sociale, Bologna, 21/22/23 ottobre
1983) si è parlato da molti punti di vista e con grande passione dello stato
delle scienze sociali oggi, in relazione al nuovo paradigma della cosiddetta
“teoria dei sistemi” introdotta in sociologia principalmente ad opera di Niklas
Luhmann. Non sono sicuro di aver capito bene tutto quello che ho ascoltato e
letto, perché non sono né filosofo né sociologo, ma alcune cose mi sono sembrate
interessanti. Il concetto di sistema, ha spiegato a un certo punto Luhmann
nella sua introduzione è di tipo “autoreferenziale”, intanto perché la
descrizione di un sistema è essa stessa un sistema, ma anche perché, in un
senso più specifico, è il sistema stesso a produrre gli elementi di cui è
costituito, in modo che la sua organizzazione in un dato momento è il risultato
dei rapporti e delle relazioni fra i suoi elementi interni. E, come è naturale,
lo stesso carattere di “aureferenzialità” è insito nella teoria dei sistemi: è
proprio questo carattere, secondo Luhmann, che consente alla teoria di
svilupparsi senza riferimenti a finalità esterne (e quindi senza infiltrazioni
di un punto di vista “morale”). Il concetto di “sistema autopoietico” (cioè autoproducentesi,
autocreantesi), Luhmann lo trae esplicitamente dalla biologia e dalla
cibernetica: il sistema biologico, o, se volete, cibernetico, è quello che è
capace di mantenersi stabile attraverso l’omeostasi,
cioè un intercambio di materia, energia, informazione, fra interno ed esterno
in grado di produrre nel sistema le modificazioni necessarie a garantire la sua
sopravvivenza in relazione agli stimoli dell’ambiente. È stato a questo punto
che mi è scattato un relai nella testa:: mi sono improvvisamente ricordato dove
avevo letto per la prima volta quel curioso termine (omeostasi): era stato verso la metà degli anni Sessanta, in un
racconto di Philip K. Dick. A quel punto ho smesso di ascoltare e mi sono messo
a divagare. Potremmo dunque considerare la fantascienza di Dick come una antesignana
delle più recenti teorie sociologiche: i suoi universi sono proprio dei “sistemi”
nel senso di Luhmann, che si autoregolano, riproducono costantemente le
condizioni della propria esistenza in modo del tutto immanente, dilatandosi
fino a comprendere nel possibile (o nel pensabile) anche l’improbabile, come
accade, per fare un esempio, in Ubik.
Ma in realtà è tutta la fantascienza, nella sua qualità di elemento egemone,
riassuntivo, dell’immaginario tecnologico contemporaneo, ad avere le
caratteristiche del sistema cibernetico. La fantascienza “sociologica” degli
anni Cinquanta si conferma in questo senso come il momento in cui questo genere
letterario basso acquista una prima coscienza di sé, e comincia a diventare
fenomeno culturale di massa, costituendo quel “polo fantastico” contrapposto a
un “polo realistico” di cui ha parlato più volte Pagetti (rimando al suo
intervento contenuto nel volume L’Einstein
perduto, atti del convegno di Ferrara del 24/26 ottobre a cura di Alberto
Poggi, Edizioni Coop, Charlie Chaplin, 1982, L. 6.000). La recente ristampa di
un romanzo di Sheckley, anche se non dei migliori, permetterà di verificare
questa tesi anche al lettore più distratto (Gli orrori di Omega, Classici FS, Mondadori, L. 3.000). Per citare
sempre Luhmann, è nel momento in cui la teoria dei sistemi riconosce se stessa
come soggetto e contemporaneamente come oggetto di indagine che nasce l’ironia: una strada che appunto la
fantascienza sociologica – e il suo rappresentante più swiftiano, che è stato
Sheckley – aveva già percorso nel rovesciamento della tradizione del romanzo
utopistico. E non è forse un caso che uno degli autori di sf che, rimessosi a
scrivere dopo anni di silenzio, riproponga la tematica della fantascienza come
autoriferimento, come autocitazione, arrivi proprio dall’esperienza degli anni
Cinquanta, e si chiami Frederik Pohl (v. il suo recente Alla fine dell’arcobaleno, Nord, L. 6.000).
Pagine
giovedì 31 dicembre 2020
Antonio Caronia: Fantascienza come sistema
mercoledì 30 dicembre 2020
Antonio Caronia: Esotiche letture
Amo l’India. Certamente un’India letteraria (quella
reale non l’ho mai vista e non so se mai la vedrò), che ho incontrato da
bambino nei romanzi prima di Salgari e poi di Kipling, e che deve essermi
rimasta dentro a maturare. In anni più recenti mi continua a stupire, con un
atteggiamento che so essere ingenuo ma da cui non mi libero, lo scarto fra la
grandiosa mitologia induista (che mi hanno aiutato ad esplorare gli splendidi
studi di Georges Dumézil) e la presente realtà, la miseria e la fame – che solo
le condizioni ancora più tristi dell’Africa hanno cancellato dall’attenzione
dei giornali – la tirannia del regime. Dopo aver letto i romanzi pazzi e
vorticosi di Salman Rushdie, di cui ho parlato puntualmente su queste pagine, mi ero accostato con qualche
diffidenza al voluminoso “Rj Quartet” (quartetto indiano) dell’inglese Paul
Scott, di cui compare adesso, tradotto in italiano dall’instancabile Roberta
Rambelli, il primo volume, La gemma
della corona, The Jewel in the Crown, (Garzanti, pp. 568, L. 15.000),
uscito nel 1966 in Inghilterra, dall’anno scorso è anche una miniserie
televisiva (14 puntate) di buona fattura, premiatissima nell’isola e
all’estero, che anche gli italiani potranno vedere prima o poi, quando una
delle reti di Berlusconi deciderà di metterla in programma (visto che è già
acquistata). In questo romanzo ponderoso e corale si parla degli avvenimenti
dell’agosto 1942 (la sconfitta britannica in Birmania, i primi appelli di
Gandhi alla disobbedienza civile) e di come essi furono vissuti nella città di
Mayapore. Lo scollamento fra la comunità indiana e quella inglese viene visto rifratto
nelle storie di alcuni personaggi, nella loro evoluzione e nei loro incontri
obliqui e problematici, con la tecnica ben nota delle testimonianze e dei punti
di vista diversi che si succedono man mano a illuminare (o complicare) il
quadro. C’è la vecchia insegnante “libera” che si scontra con la realtà brutale
dei disordini e della morte, la giovane infermiera bruttina che rimane vittima
di una violenza nei giardini del Bibigha, il poliziotto inglese innamorato che
ha già scelto come vittima il giovane indiano occidentalizzato che si rifiuta
di parlare persino la sua lingua, la saggia e disincantata lady indiana
testimone del cambiamenti. Certo Scott non è Rushdie, e neppure Durrell: però
mostra di conoscere bene l’India, e per lenta sovrapposizione costruisce un
quadro illuminante (anche se non sempre intrigante) dei rapporti fra due
civiltà così diverse. Non senza qualche buona arguzia britannica, come questa
definizione che degli inglesi dà la vecchia lady indiana: -Siete uno strano
popolo. Quando camminate al sole, siete consapevoli della lunghezza o della
brevità delle ombre che gettate sul suolo-. Il tema dello scontro fra due
culture è anche al centro dei tre racconti di London che Sandro Roffeni ha
raccolto e ci presenta col titolo di uno di essi, Il rosso, (Sugarco, pp. 142, L. 8.000). Sono tre storie ambientate
nei mari del Sud, scritte da London nell’anno stesso della morte, il 1916.
Quella che dà il titolo alla raccolta è il resoconto di una sfida e di una
sconfitta: un bianco prostrato dalle malattie equatoriali tenta di penetrare il
segreto della lontana divinità a cui gli indigeni di Guadalcanal (Isole Salomone)
tributano efferati sacrifici. Mentre la tribù che lo ospita attende ansiosa il
momento della sua morte, Bassett riesce a intuire l’origine extraterrestre
dell’enorme uovo senziente, il Rosso, che gli indigeni considerano dio, ma non
sopravviverà per portare la notizia in Patria. È la sconfitta della razionalità
occidentale che non riesce a superare la prova di questa vera e propria discesa
agli inferi costellata delle ossa dei sacrificati al Rosso. Di ossa parlano
anche gli altri due racconti, ambientati invece nelle isole Hawaii, e
indubbiamente più “solari”. Tuttavia anche nell’ultimo racconto, Tibie, che personalmente ho apprezzato
di più, si narra di una discesa nella notte, nel passato rappresentato dal
luogo segreto dove riposano le ossa degli antenati di un giovane principe
hawaiano. La spedizione è descritta magistralmente, con un piede sul pedale
dell’orrore e l’altro su quello dell’ironia, fornita dal contrasto fra il
giovane principe ormai occidentalizzato e miscredente e il vecchio e tremebondo
servo. Ormai alla fine della vita, London è in grado di trattare con inedita
leggerezza uno dei suoi temi preferiti, lo scontro della civiltà con le forze
della natura e della tradizione.
martedì 29 dicembre 2020
Antonio Caronia: Dopo l'uomo
Linus maggio 1983
“Era profondamente radicata in loro la percezione
che nell’Universo niente esiste come Materia, ma che tutto è Energia. Che noi
tutti siamo solo ombre della stessa Energia, che niente e nessuno possiede
un’identità propria. Che non esistono cose;
e che, in realtà, l’elemento caratterizzante l’Universo consiste nella sua inesistenza.” Troviamo questa sintetica
esposizione divulgativa dell’ipotesi idealista, a mezza strada fra il vescovo
Berkeley e le dottrine buddiste, in Tempo
di mostri, fiume di dolore di James Kahn (Urania n. 934, pp. 264, L. 1800)
che presenta l’ennesima versione del mondo “dopo la catastrofe”: ma con tale
ricchezza di scenari, particolari e riferimenti, da farne un utile repertorio
di temi e figure dell’immaginario fantascientifico di questi ultimi anni. Qui
risiedono le ragioni dell’interesse del romanzo, più che nell’andamento
narrativo, abbastanza tradizionale anche se fluido e a tratti serrato. Ecco lo
scenario: nel 24° secolo l’avanzata dei ghiacci ha ristretto l’abitabilità
della terra a ristrette fasce temperate, ma l’umanità arriva all’appuntamento
falcidiata dalle precedenti guerre nucleari e biologiche. In una America frazionata
in piccoli territori e comunità, i pochi umani convivono con una pletora di
esseri da incubo, usciti dalla fantasia dell’uomo dei secoli precedenti:
Vampiri, Centauri, animali pensanti e parlanti, fino agli esseri artificiali
più sofisticati, i Neurumani, corpi sintetici costruiti attorno a un cervello
umano, isolato e tenuto in vita con tutto il bulbo spinale. È evidente quanto
uno scenario del genere debba a Ballard, a Delany, a Farmer: il confronto con l’ultimo
romanzo di quest’ultimo, Il sole nero
(di cui si è parlato su queste pagine qualche mese fa) (1) si impone anche per la somiglianza di due dei protagonisti, il
centauro Beauty nel romanzo di Hahn, e l’essere vegetale Sloosh in quello di
Farmer. Ma sono evidenti anche le differenze: mentre Farmer si limita a mettere
in scena i suoi personaggi, i suoi esseri mitologici, lasciando nell’ombra la
loro origine, e anzi insinuando nel finale il dubbio che quel mondo sia proprio
il nostro mondo, Kahn si preoccupa di dipingere un quadro razionale, e di
informarci che vampiri, centauri e altri esseri fantastici sono il prodotto di
manipolazioni genetiche su larga scala. Quale che sia la loro origine, però,
tutti questi abitatori della fantascienza più recente alludono, con le loro
forme e lo spazio che si portano dietro, ad un mondo che, per essere
fantastico, non è meno attuale: un mondo in cui il posto centrale non è più
occupato dall’uomo e dai sistemi di relazioni, di psicologie, di motivazioni ad
esso collegati, ma dagli esseri (o, a volte, solo dalle funzioni) artificiali
di cui l’uomo stesso, negli ultimi decenni, ha già cominciato a circondarsi. È una
società post-umana quella che la
fantascienza più recente ci descrive: è quella che Ridley Scott, forzando forse
il testo ma non l’insieme dell’opera di Dick, ha messo insieme così
efficacemente in Blade Runner, una
società in cui l’uomo non è scomparso, ma deve affrontare tutti i nuovi e
sconvolgenti problemi che derivano dalla coabitazione con un insieme di forme
di vita artificiali, prodotte da lui stesso eppure dotate di logica,
sensibilità, comportamenti, aspettative, strategie a lui estranee. Nonostante
la similarità degli argomenti e degli scenari, non è più della vecchia
fantascienza catastrofista degli anni 50 e 60 che si tratta, ora, ma del
riconoscimento (con tutta la paura e l’angoscia che questo ancora comporta) che
l’uomo, anche prima del fatidico incontro con gli esseri provenienti da altri
mondi, non è più solo, già oggi, su questa terra; che bisogna scoprire poco a
poco, o inventarsi tutto d’un colpo, un nuovo modo di convivere con i prodotti
della nostra creatività.
(1)
Meglio morti che immortali, in
Linus novembre 1982 QUI
lunedì 28 dicembre 2020
Antonio Caronia: Confessioni di un mangiatore di carta stampata
Linus dicembre 1980
-Ah-, dice, -voi siete quelli che scrivono su Linus-, -Eh,
sì-, rispondiamo noi, e poi ci vergogniamo un po’ e nervosamente cerchiamo di
parlare d’altro, perché ci sembra che la domanda successiva debba essere: -Ma
che ci scrivete a fare?- (come, un po’ di anni fa, davanti alle fabbriche, ci
chiedevano: -Ma chi vi paga?-). Che sia una crisi di identità con tutti i
crismi, o un semplice momento di astenia autunnale, ci stiamo chiedendo da un
po’ (ed è per questo che temiamo che gli altri ce lo chiedano) che cosa voglia
dire questa nostra rubrichetta di segnalazioni, polemiche e varia umanità:
anche perché –va detto- ci pesa la maniera poco educata con cui l’abbiamo
iniziata, alcuni mesi fa, così, subito nel merito senza neppure presentarci
brevemente. E non opponeteci che nelle nostre angosce scribacchino-esistenziali
a voi lettori manovratori-manovrati di-da quella macchina dal bizzarro
funzionamento che è il mercato, poco importa. Perché è dalla risoluzione, o
meno, di queste angosce che dipende il fatto che noi scriviamo cose frizzanti e
intelligenti, oppure delle vaccate. E quindi, fedeli ad una concezione
tardo-democratica del rapporto scrittura/fruizione, di queste angosce facciamo
partecipi anche voi, che se in fondo siete tutti diventati dei “lectores in
fabula” è anche colpa vostra. Non cercate neanche di prenderci in castagna
ricordandoci, con aria di sufficienza, che nella società dei simulacri il senso
implode, che la distanza tra reale e immaginario è abolita, e quindi che senso
ha chiedersi che senso c’è. Eh: Baudrillard, Lyotard, Perniola e Vattimo li
leggiamo anche noi: e tutte quelle cose lì le abbiamo anche già dette e
scritte, quando il problema era di fare bella figura. Ma guardate che anche
fare gli alfieri del non senso mica è facile: non basta dire: -Ah
dimenticavamo: il senso è imploso, e tutto denota tutto e perciò non connota
più niente-. Forse è un passo importante, però magari l’hanno già fatto i Wutki
più di dieci anni fa su un giornalino che si chiamava come questo. Certo, si
può fare come quelli di Frigidaire, che dicono: -Non chiedetevi che rapporto c’è
fra tutto quello che trovate qui dentro, perché tanto anche la vita è
incasinata, e questa rivista, che non è niente di meno, anche-. Sfido: quelli
si chiamano Pazienza, Scozzari, e così via, e possono anche far finta di essere
la vita. Ma qui è un’altra cosa. Ricapitoliamo. Quando l’O.d.B. ci ha chiesto
di tenere questa rubrichetta per parlare della fantascienza, segnalare i libri,
fare le nostre polemiche (con moderazione), noi,
collettivo/cooperativa/redazione di rivista/adesso anche libreria, agenzia
fotografica e tutto quello che siamo, abbiamo accettato con entusiasmo, perché
eravamo convinti che questo discorso sulla fantascienza fosse sottovalutato,
preso sottogamba un po’ da tutti. Ci siamo detti: -Bene, ecco un’altra
occasione per cercare di capire meglio questo rapporto tra fantascienza e
realtà, per capire quanto nella nostra vita è diventato fantascienza (o quanto
la fantascienza è diventata la nostra vita)-. Perché a noi il problema sembrava
questo, e ci esaltavamo ancora, trovavamo la forza di meravigliarci nel vedere
quanta parte dell’immaginario, del repertorio di immagini
tecnologiche/sociologiche/antropologiche/alienontologiche della fantascienza si
stesse trasferendo nella nostra vita quotidiana. Ecco: poi, forse, dietro alle
novità librarie, alle polemiche con quelli che della fantascienza hanno ancora
un’immagine e una pratica che a noi pare vecchia, quel discorso non siamo
riusciti a farlo. O non siamo riusciti a farlo molto chiaro: forse anche perché
i primi a non averlo chiaro eravamo noi. Però l’intenzione era questa, e se non
ve l’avessimo detto, forse non si sarebbe capito perché adesso vi parliamo di
un piccolo convegno a cui siamo stati e che, un poco, ha contribuito a renderci
meno confuse le idee.
https://un-ambigua-utopia.blogspot.com/2019/10/antonio-caronia-fra-codice-e-codice.html
domenica 27 dicembre 2020
Antonio Caronia: Euro Cannes
Come vi abbiamo accennato due volte fa, ai primi di
maggio c’è stato il quinto convegno europeo di fantascienza (Eurocon, in gergo: le associazioni
evocate da una lettura in francese di questa sigla non sono affatto, ovviamente,
imputabili agli organizzatori) svoltosi nella cornice del deplorevole e
deprimente palazzo dei congressi di Stresa. Cornice per altro abbastanza in
sintonia con il programma e lo svolgimento ufficiale del convegno stesso, su
cui spenderemo adesso qualche riga. I lettori considerino, per favore, che il
nostro è un punto di vista di un collettivo abbastanza anomalo nel panorama
della fantascienza italiana: abbiamo i nostri “autori preferiti”, ma non
sbaviamo vedendoli di persiona (alcuni incontri, con Bester e Brunner, per
esempio, ci hanno confermato nella convinzione che in genere è meglio evitare
di far parlare gli autori di sé stessi); ci sforziamo di avere delle idee su
come si potrebbe fare una buona politica editoriale nella fantascienza, ma non
abbiamo interessi editoriali da difendere; e via di questo passo. Per questo,
inevitabilmente, non ci piacciono quasi mai le stesse cose che piacciono agli
altri appassionati, detti, con stucchevole barbarologismo, Fans (mentre l’insieme di cui essi fanno parte viene detto Fandom). Siamo perciò convinti che a
molti di costoro l?Eurocon sia
andato bene così com’era. A noi no, e cercherò di spiegare il perché. C’era
innanzitutto la questione del premio: l’idea del premio non ci entusiasma in
genere, in nessun campo e in nessun settore: ma questi premi, assegnati all’Eurocon passavano proprio la misura.
Non si scopre l’America dicendo che dietro ai premi ci sono interessi
editoriali precisi, anche se gli editori interessati all’Eurocon smentiscono inorriditi (ma allora il loro accanimento nel
disputarseli andrebbe spiegato con improbabili sindromi demenziali, nelle quali
non crediamo). Per il premio Italia, dal risultato e dalla distribuzione dei
voti, pare di capire a noi, dall’esterno, che esso sia stato il risultato di un
accordo tra l’Editrice Nord, di Gianfranco Viviani (il quale in qualità di
coordinatore dell’Eurocon, ne ha
avuto il principale onore e onere), e l’editore Fanucci, e in genere l’area di
destra: alla Nord il premio per il miglior romanzo e la migliore collana, alla
destra quelli per la migliore fanzine
e il miglior saggio. Noi, che siamo in fondo un collettivo educato, non avremmo
preteso però di dire proprio queste cose dalla tribuna del premio: ci saremmo
limitati a leggere una dichiarazione molto più generica sull’imbecillità dei
premi, se la presidenza, nella persona del suddetto Viviani e (spiace dirlo) di
John Brunner, non avesse deciso per noi, togliendoci bruscamente la parola.
Pazienza, sarà per un’altra volta: l’imbecillità è un tema che non tramonta
mai… Poi c’è la questione dei soldi_ per accedere all’Eurocon occorrevano la bellezza di 25.000 lire (18.000 se si era
prenotato in anticipo): e in cambio si aveva una mostra di libri stranieri (non
in vendita), alcuni stand di librerie di editori (4 in tutto) e una rassegna di
film su cui non diciamo nulla perché non ci piace infierire. L’attento
osservatore avrebbe poi notato che il manifesto ufficiale dell’Eurocon non era altro che la copertina
del catalogo dell’Editrice Nord. Non conosciamo il bilancio di questa società,
ma abbiamo l’impressione che il capitolo “campagne promozionali” non riguardi
tutte quelle effettivamente messe in atto. E veniamo al difetto più grosso: il 5° Eurocon, come in genere tutte le
manifestazioni di questo tipo, è servito agli editori e ai professionisti
(quelli che ci sono venuti) per farsi pubblicità, scambiarsi idee, prendere
accordi; agli appassionati “organizzati” in rivistine, circoli, etc., per
rivedersi, fare nuove conoscenze (e in questo senso, certo, è servito anche a
noi), appagare il proprio feticismo. Non è servito ai lettori “normali”, e per
fortuna ce n’erano pochi. Nella sala del congresso gli interventi si
susseguivano, preparati da mesi, nella solita passerella, senza alcuna
comunicazione gli uni con gli altri. Quei pochi spazi di discussione che ci
sono stati li abbiamo organizzati noi, a lato e nell’indifferenza del convegno
ufficiale. Da quelle riunioni è uscita l’idea, che ci siamo incaricati di
rendere pubblica: quella di un incontro tra appassionati e lettori di
fantascienza organizzato in modo diverso: poche relazioni preparate (due, tre),
tanto spazio per la discussione, anche per chi ha da dire poche cose e non se
le scrive in anticipo: il tutto in uno spazio, possibilmente, più adatto di Stresa
alla moltiplicazione degli incontri e delle discussioni. Noi ci ritorneremo
sulle pagine di Un’Ambigua Utopia:
voi, comunque, fateci sapere che cosa ne pensate.
venerdì 4 dicembre 2020
Dal cyborg al postumano di Antonio Caronia. Recensione di Giuliano Spagnul
Molto acutamente Alberto Abruzzese, nella prefazione
al libro “Dal cyborg al postumano. Biopolitica del corpo artificiale” per le
edizioni Meltemi, (1) nel declinare le tre fasi di “approfondimento e
raffinamento della (…) particolare prospettiva politico-culturale” di Antonio
Caronia, assieme all’insegnamento nella scuola e alle lezioni in contesti
accademici, pone la sua laurea in matematica “che gli ha conferito una
specifica competenza nel trattare testi e processi solitamente in mano a altre
discipline.” È una doverosa sottolineatura, ancor più perché si tende
facilmente a dimenticarsene. Certo, che ci fosse una competenza di stampo
scientifico e un forte interesse a coniugare l’immaginario con la scienza era
più che evidente in lui; anche se difettava di quel cipiglio un po’ arido e
freddo che si vorrebbe caratteristica degli uomini di scienza e, in particolare,
di quelli dediti alla matematica, scienza tra le più pure. Ma in realtà, forse,
era proprio questa la matrice che gli permetteva di spingersi più oltre di
tanti altri, nel cogliere il peso determinante che le astrazioni del fervido
immaginario umano (quella capacità di costruire mondi virtuali in cui
sperimentare i sogni più arditi) hanno sulla vita reale e concreta di tutti noi.
E ancora Abruzzese nota, giustamente, nel desiderio di Caronia, celato
nell’invito a dimenticare il Novecento (secolo delle rivoluzioni fallite), la
speranza di una nuova via di liberazione dal potere “finalmente possibile a
ragione della scomparsa del corpo umano dentro un corpo che non soffrisse più
degli inganni della natura spietatamente antropocentrica e della violenza della
forza sovrana che ne ha fatto irreversibile strumento di dominio.” È il tema
del postumano, da sempre centrale per Caronia e che proprio lui tradisce negli
ultimi mesi di vita preferendo dedicarsi a un seminario su “arte e follia” a Macao,
invece che alla stesura di un articolo richiestogli per il numero di Aut Aut
dedicato proprio al postumano. Di quell’articolo non sono rimaste tracce,
nessuna nota o appunto, solo un’entusiasta mail agli amici per condividere la
gioia di questa inaspettata richiesta. È vero quel desiderio, a cui accenna
Abruzzese, desiderio più che umano di andare oltre l’umano ma è vero che
proprio Caronia poteva vantare di averne lucida coscienza, accompagnata da
un’altrettanta lucida autocritica . (2) Cos’altro avrebbe potuto dire, in quel
momento, sul postumano che non avesse già ribadito con forza più volte, e cioè
che non di un superamento del corpo (in una sorta di divenire angelico) si
tratta, ma del finire delle condizioni di un determinato sapere (episteme) e di
“una nuova nascente episteme”. È questo che sta a significare per Antonio Caronia la parola postumano. Una
nuova parola per una vecchia storia che sempre, a più riprese, si è presentata
lungo l’arco della storia evolutiva della nostra specie: la trasformazione dei
dispositivi di formazione di un nuovo sé, quei dispositivi che nell’epoca
appena trascorsa hanno costruito quell’”Io” del soggetto moderno e che in
questa nuova epoca, modificati, ne stanno costruendo uno affatto nuovo.
Cos’altro avrebbe potuto aggiungere in un volume dedicato al postumano se non
uno scontro/incontro con il proprio corpo, carnale, artificiale, immaginato che
sia: e questo ha fatto optando per il silenzio delle parole scritte a favore di
quelle orali, vis-à-vis, con altri umani, altri corpi, come il suo soggetti ad
ammalarsi e a perire, non prima però di aver espresso tutta la loro voglia del
vivere e di gioire. È giusto quindi che questa antologia di scritti inizi con
un testo non scritto, una lezione all’Accademia di Brera nella tarda primavera
del 2010. Per chi considera la biopolitica foucaultiana come un teorema
superato dall’evoluzione odierna degli strumenti tecnologici e della loro
capacità di operare, o meno, sulla viva carne degli individui, questa lezione
sulla nascita della biopolitica, coestensiva a quella dell’uomo artificiale
(robot, androide, cyborg che sia) chiarisce in modo esemplare l’essenza di
questo concetto, così spesso frainteso nonché abusato. La biopolitica è il
punto di snodo in cui la storia umana concepisce l’idea della “modificabilità
della natura” da parte dell’uomo e questo nuovo sapere determina un potere che
necessariamente deve servirsi di nuovi dispositivi capaci di modificare la
natura dell’essere umano stesso. All’artificialità della natura corrisponderà,
d’ora in poi, l’artificializzazione dell’umano: “non ci sono più uomini
naturali una volta che è comparso l’artificio all’orizzonte della specie
umana.” E al potere non basterà più esercitare la pura sovranità o un regime
disciplinare (di addestramento all’obbedienza), occorrerà, per perpetuarsi,
fare quel salto enorme di rendere governabile la vita in tutte le sue forme, da
quella individuale, a quella sociale, a quella immaginale, a quella biologica
fino ai suoi recessi più profondi e intimi: “la biopolitica vuol dire che è
stato reso governabile l’ingovernabile.” Antonio Caronia ha capito che, in
realtà, Foucault non ha fatto altro che parlarci di biopolitica (nonostante che questo termine compaia solo
alla fine del corso del ’76) (3) anche quando si è messo minuziosamente a
raccontarci la storia della sessualità o i processi di soggettivazione della
Grecia antica come del primo cristianesimo. Tutto il suo lavoro tende verso
quell’”irruzione della naturalità della specie umana all’interno dell’ambiente
artificiale” (4) che Caronia si spinge a completare modificandolo in una forma
più consona all’oggi: “l’irruzione della naturalità della specie umana
all’interno dell’ambiente artificiale determina l’artificialità della stessa
natura umana, la trasformazione artificiale della stessa natura umana.”
Schematizzando, credo che Antonio Caronia abbia voluto, tramite Foucault, dirci
che la natura dell’uomo consiste nella sua progressiva artificializzazione e
che per biopolitica si deve intendere quella possibilità di rendere questo
processo governabile, nel suo divenire sempre più, di fatto, ingovernabile. La
questione non è quindi la comparsa di qualcosa di nuovo che chiameremo
biopolitica, come se non fosse mai esistita una politica che in un qualche modo
abbia cercato di governare la nostra vita, ma piuttosto della sua inedita e
inaudita potenza che oggi ha assunto grazie al nuovo sapere-potere che le ha
conferito la fusione tra scienza e tecnica, con progressione esponenziale in
questa fine e inizio di nuovo millennio. Questo libro, curato sapientemente da
Loretta Borrelli e Fabio Malagnini, suddiviso in tre parti, sostanzialmente
riguardanti il cyborg, la fantascienza e il postumano, in realtà ci accompagna in
un percorso che oltre a volerci far “dimenticare il Novecento” vuole anche
farci uscire dalle secche di quel linguaggio a lui ancora strettamente legato.
Né il cyborg, né il postumano, né la fantascienza tutta (di basso o alto
livello che sia) possono pensare di essere traghettati nel nuovo
secolo/millennio senza essere depurati da quelle croste di residui utopici o
prometeici peculiari di un tempo irrimediabilmente finito. “La fantascienza (non
si può non essere d’accordo con Ballard) è stata l’immaginario portante del XX
secolo (…) la fantascienza sarà ancora l’immaginario portante del nuovo secolo?
La risposta è più probabilmente no che sì. La fantascienza cadrà vittima (forse
è già caduta vittima) di quel processo che ha saputo così bene illustrare, e
nei casi migliori interpretare, quello della caduta del cielo dell’immaginario
sulla terra del reale.” (5) Quando la fantascienza si cala nella realtà fino ad
annullare, di fatto, quella distanza indispensabile, “quel minimo scarto fra
progettualità e realizzazione” si rende impossibile l’esistere di quella zona
franca in cui poter immaginare i possibili potenziali, tutto rimane schiacciato
entro i confini di quel contingente sempre più dato come unico possibile. La
parola fantascienza deve quindi, per noi del nuovo millennio, dirci qualcosa di
scandalosamente nuovo. Qualcosa che “non ha più niente a che vedere con il
futuro della modernità, che era una proiezione del presente del soggetto, un luogo
da costruire con pazienza, sagacia e tenacia, nei tempi lunghi del lavoro e
della progettualità” ma, invece, con un futuro che assomiglia “piuttosto a uno
spasmo del presente, a un’anticipazione frenetica di processi che non si
distendono più dal passato al presente e oltre, ma vivono sin dall’inizio
perennemente proiettati in avanti.” (6) E allora la fantascienza oggi deve
essere una parola nuova che come quella che dice cyborg o postumano deve
definire un concetto piuttosto che un’essenza. E questi concetti, questi modi
nuovi di pensare e di pensarci, maturano in una fase storica di violenta
accelerazione tecnologica in cui è, e sarà, sempre più necessario fare i conti
non con ciò che è dato, certo, a cui si può fare affidamento, ma a ciò che è
mutevole, incerto, non definito. Perché una realtà che non può più contare su
un futuro da immaginare, programmare e realizzare rende obsoleti quei confini
tra dato e immaginato che vivevano ancora entro
quella forzatura ossimorica che stava alla base della parola
fantascienza. Alla fine questa ottima scelta antologica, io credo, ci ponga di
fronte a quello che è il nodo centrale per riuscire a sopravvivere all’utopia
capitalista (unica uscita vincente dal secolo appena trascorso), quello di
considerare il tempo in cui stiamo
vivendo in sostanziale continuità o discontinuità con quello passato. Cioè se
il futuro è realmente scomparso, se la cultura non può più essere considerata
elemento estraneo alla natura, se lo spazio del virtuale non è più uno spazio
immaginato ma è esperito e vissuto nella nostra quotidianità in quanto ne
facciamo ormai completamente parte e i tanti altri se che Caronia pone ci
costringono a una presa di posizione, che per quanto riguarda lui non può che
essere che quella di assumersi la responsabilità di divenire postumani e quindi
in sostanziale discontinuità con ciò che ci siamo lasciati alle spalle. Una
nuova difficile, ancorché inquietante e insieme esaltante, costruzione di un
nuovo ibrido, ennesima variante di una (come Caronia amava descrivere la nostra
storia di specie) tra le più sofisticate sperimentazioni della natura. Non è
detto che debba andare per forza bene, e l’avveramento dei più arditi sogni del
capitalismo non possono non prefigurare l’esito infausto di quest’avventura. Per
farcela non avremo bisogno di nuove utopie ma di una storia fatta di parole
nuove che ci permettano di costruire “tattiche di resistenza, nella forma di
‘slittamenti temporali’, quelle fughe nel futuro e nel passato di cui ci
parlava Philip K. Dick. (…) Per non farci trovare mai lì dove si pensa che
dovremmo essere per fare la nostra parte di agenti valorizzatori, di
colonizzatori del tempo per conto terzi”. (7) E poi? E poi è una domanda che
appartiene a una storia finita, chiusa. A noi serve una storia aperta dal
finale non scontato, perché noi, nonostante i sogni del capitale che ci
vorrebbe tutti morti, siamo ancora vivi.
Nota 1: Antonio Caronia, Dal cyborg al postumano. Biopolitica del corpo artificiale, a cura di Loretta borrelli e Fabio Malagnini, Culture Radicali, Meltemi editore, 2020.
Nota 2: Nel ricordo per Enrico Livraghi: “E capivo
che lui mi etichettava spietatamente ma con una certa tolleranza tra gli
‘antropologhi ottimisti del cyberspazio’ (…) e riluttavo allora, mentre capii
poi che nell’essenziale aveva ragione.” http://un-ambigua-utopia.blogspot.com/2015/06/antonio-caronia-per-enrico-livraghi-da.html
Nota 3: Michel Foucault, Bisogna difendere la società, Feltrinelli 1998
Nota 4: M. Foucault, Sicurezza Territorio popolazione, Feltrinelli 2005
Nota 5: A. Caronia, L’insostenibile
naturalità della tecnica, 1999
Nota 6: A. Caronia,
Digital Time, 2008
Nota 7: idem
Pubblicato su La Bottega del Barbieri Qui (18 agosto 2020)
altre recensioni:
Luca Giudici in Quaderni D'Altri Tempi Qui (30 ottobre 2020)
Francesco Monico in Che Fare Qui (4 novembre 2020)